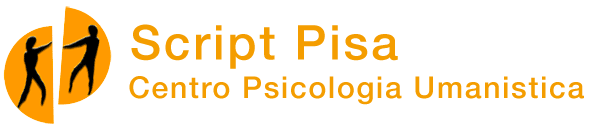Fare teatro con gli afasici è un’utopia. Fare teatro ha significato da sempre usare la parola, metaforizzarla per avere accesso ad altri mondi. Nel teatro tradizionale e anche nella teatroterapia la parola è usata come tramite polisignificante. Se ne possono fare usi molteplici: enfatizzarla, naturalizzarla, scorporarla, camuffarla. Se c’è. E il gesto attoriale è un valore aggiunto che rafforza e arricchisce la parola stessa.
Cosa succede quando il linguaggio è ferito? Per fare teatro ci si può valere esclusivamente della mimica e del gesto, ma questi per essere funzionali all’espressione hanno bisogno di provare una correlazione semantica. Se l’afasia impegna le aree semantiche del linguaggio il rischio è che il gesto attoriale sia una imitazione povera e indotta molto vicina alla stereotipia.
Il lavoro di ricerca del teatro degli afasici dovrebbe avere come fondamenti teorici la psicoterapia espressiva attiva, ovvero una tecnica terapeutica basata sull’espressione e sul trattamento dei contenuti e dei sintomi del paziente attraverso la stimolazione delle azioni. Nello stesso tempo dovrebbe avvalersi dei portati della psicoterapia corporea e della bioenergetica, dove il corpo è contemporaneamente significante-significato, dove il corpo può, in alcuni casi, arrivare a sostituire la parola. Il teatro della “parola reclusa” si trasforma in laboratorio dell’azione del corpo, luogo di amplificazione delle reti espressive interne collocate e traslate nella rappresentazione teatrale. Le reti espressive interne non sono altro che legami che si stabiliscono fra le emozioni, appartenenti al mondo dell’intelligenza ana-logica, per contrasto alla parola che appartiene prevalentemente all’intelligenza dia-logica. L’emozione quindi potrebbe essere la matrice di senso nel teatro–afasia, espressa attraverso il corpo per riattingere alla parola; nel teatro-afasici l’emozione svela la parola, così come, con un processo inverso, nel teatro tradizionale la parola svela l’emozione.
Plutchik (1984) definisce l’emozione come “una sequenza complessiva di reazioni a una situazione attivante e include valutazioni cognitive, cambiamenti soggettivi, attivazione del sistema nervoso centrale e modificazioni anatomo-viscerali, una spinta all’azione, nonché un comportamento designato ad aver effetto sullo stimolo che ha iniziato la sequenza complessa.”
L’emozione appare quindi come un costrutto psicologico complesso che comprende una componente cognitiva per la valutazione della situazione, una componente fisiologica di attivazione, una componente espressivo-motoria, una componente motivazionale che si esprime nell’intenzione e nella prontezza a reagire nonché una componente soggettiva relativa al vissuto dello stato affettivo.
L’emozione è espressione verbale, è semplice azione, è conseguenza funzionale del processo emozionale e, soprattutto, è l’integrazione di queste tre modalità (o linguaggi). Attraverso il teatro, anche dove è assente la parola, è possibile valorizzare e lavorare sulle parti emozionali complementari perché queste possano essere canali espressivi adeguati al vissuto.
Si riconosce un certo numero di emozioni primarie o fondamentali che sono innate e universali: Gioia – tristezza, paura – collera, accettazione – disgusto, anticipazione – sorpresa: ma ogni emozione varia lungo dimensioni in continuum. Così la collera può accentuarsi fino a diventare rabbia o attenuarsi nell’irritazione e nel fastidio.
Le emozioni sono una particolare modalità di relazione fra l’organismo e il proprio ambiente fisico e sociale, in grado di mediare costantemente il rapporto tra il flusso degli eventi e le risposte dell’individuo. Infatti il loro ruolo funzionale consiste nella elicitazione, nel mantenimento e amplificazione nonché nella guida e rinforzo del comportamento. Ed è una modalità fondamentale di adattamento attivo dell’organismo al proprio ambiente. Le emozioni, da un lato, mantengono uno stato di attenzione, di vigilanza e di reattività nei confronti dell’ambiente; dall’altro, aumentano la rapidità e la precisione nella raccolta e nell’elaborazione delle informazione più cariche di significato per l’individuo; dall’altro ancora, regolano l’organismo per intervenire in modo tempestivo e appropriato nei riguardi dell’evento emotigeno.
Le emozioni amplificano la forza delle motivazioni, riescono a modularle nel tempo e a orientarle verso il loro soddisfacimento. Le espressioni emozionali, che hanno precise configurazioni motorie, costituiscono una sorta di “veicolo pubblico di attività privata” (Lewis e Michalson, 1983). Hanno un elevato valore evocativo riferito all’oggetto/stimolo, poiché indicano l’importanza a esso attribuita da parte del soggetto e manifestano il modo con cui quest’ultimo si riferisce a esso. Il comportamento espressivo è eminentemente un’attività razionale in quanto fa parte del processo emotivo, volto a realizzare o a modificare la relazione fra il soggetto e l’ambiente. Nello studio delle specifiche configurazioni espressive motorie attraverso le quali si manifestano le varie emozioni sono oggetti di analisi il volto e la mimica facciale, lo sguardo, i gesti e gli altri movimenti del corpo, la postura, la prossemica, nonché il sistema degli indicatori paralinguistici e vocali. Sintonizzazione, quindi, con la P.A.C.E. (Promothing Aphasics’ Comunicative Effectiveness, in Metodologia Logopedica di Davis e Wilcox, 1978) in quanto processo globale.
L’esperienza emozionale grazie alla complessità delle strutture nervose centrali e periferiche coinvolte, all’interazione con i sistemi cognitivi e alla sua rilevanza sociale risulta essere un’esperienza intenzionalmente controllabile soggetta a processi di regolazione. Con questo termine si intende l’insieme delle strategie adottate dal soggetto per favorire la corrispondenza reciproca fra gli elementi del sistema credenze-desideri-emozioni, nonché per adeguare l’esperienza interna e la manifestazione esterna al contesto sociale di riferimento.
Quindi: le emozioni costituiscono un sistema psichico complesso e multicomponenziale in grado di consentire all’essere umano un’aderenza flessibile e varia al flusso degli eventi, di contribuire a regolare le rappresentazioni mentali, nonché di qualificare e vivificare i rapporti interpersonali e sociali all’interno di giochi relazionali complessi e degni di interesse.
Le emozioni (Wallon, 1949) possono essere considerate come l’origine stessa della socialità e la cerniera fra l’organico, lo psichico e il sociale. Infatti le emozioni costituiscono un sistema che interagisce con gli altri strumenti psichici, in grado di fornire informazioni sullo stato dell’organismo nell’affrontare le notevoli e imprevedibili condizioni dell’ambiente nonché di organizzare il sistema regolativi (espressivo e comportamentale) per far fronte alle richieste provenienti dal medesimo ambiente. In quanto tali le emozioni rappresentano, nella loro varietà e popliedricità, altrettanti scenari prototipici con cui ogni individuo si confronta e si misura con la propria rete relazionale e, più in generale, con la realtà sociale, in termini di benessere o di disagio psichico.
Flora Gagliardi
E-mail: flora_gagliardi@yahoo.it
Bibliografia:
H.Wallon (1949). Le origini del carattere nel bambino. Editori Riuniti, Roma 1974
H.Lewis, L.Michalson (1983). Children’s and Moods. Plenum Press, New York, 1983.
R.Plutchik (1984). Approches to Emotion.Erlbaum, Hillsdale, 1984.