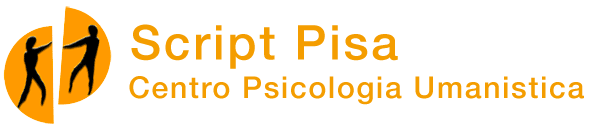Da “Il manifesto” quotidiano 20 dicembre 2012
“Il coraggio dell’incertezza”, questo il titolo del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi all’Università di Paris Ouest. Riflessioni sul modo in cui è vissuta e rappresentata la precarietà e sui luoghi dove, nonostante tutto, si sviluppa il pensiero critico.
Ci sono voluti decenni, nell’Europa industriale, perché la soddisfazione soggettiva di un lavoratore per la propria attività venisse riconosciuta come variabile economica. E ora, soprattutto in Italia, il primo indicatore a cui l’avventura del capitalismo globale ha voltato le spalle è proprio questa: lo stare bene in ciò che si fa. In compenso è nato il mito dell’avventura solitaria, dell’agile danza sul vuoto dei ponti che crollano dietro le spalle. Basta guardare all’Italia, terra di conquista del precariato diffuso, e terra di sedimentazione delle ipotesi narrative su queste nuove forme del lavoro che si è messo a tremare, che non risponde più alle chiamate dei nostri anni così slabbrati.
Ascanio Celestini, l’autore di Fabbrica (2002) e degli Appunti per una lotta di classe(2006), incontra i partecipanti al convegno “Avoir le courage de l’incertitude”, nell’anfiteatro universitario dell’edificio V di Paris Ouest; poi dà una performanceall’Istituto Italiano di Cultura di rue Grenelle. Giorgio Vasta, l’autore del Tempo materiale (2008) e di Spaesamento (2010), parla dell’ Esperienza dell’umiliazione – la parola suona forte e piuttosto azzeccata – al tempo della crisi; Andrea Inglese, parigino d’adozione, autore della Confusione è l’ancella della menzogna (2012), rilegge l’idea contemporanea di lavoratore culturale, a partire da quella – così amara, così terribilmente scritta nelle cose – che Luciano Bianciardi aveva raccontato con la valigia in mano, dalle quattro strade di Grosseto al disinganno della capitale del Nord, sul finire degli anni Cinquanta.
Il problema è quello, appunto: inutile girarci intorno. Chi non ha un minimo di solidità sotto i piedi non può andare dove vorrebbe. La stessa iniquità sociale che gli si proietta sopra fino a schiacciarlo – così ha detto al convegno Christian Laval, sociologo a Paris Ouest, autore dell’ Homme économique (2007) e dell’ Ambition sociologique (2012) – gli dà l’etichetta del coraggioso, dell’eroe di cappa e spada, del nomade che ogni notte conta le stelle, ignaro di come sopravviverà al giorno dopo. Una strana specie di don Chisciotte neoliberale, la cui sete di conoscenza è già spettacolo, è già fiction, anche prima che il viaggio inizi.
Anche Antonio Gramsci si era soffermato, in carcere, ai primi anni Trenta, quando si chiedeva perché in Italia aumentassero le tirature dei Tre moschettieri e dei romanzi polizieschi, cioè della “letteratura non artistica”, come si diceva all’epoca: e nel Quaderno 21, paragrafo 13, rispondeva che quel bisogno di avventura, quella specie di oppio da lettura compulsiva ed evasiva, non era derivato dalla razionalizzazione sociale dell’industria, né da un eccesso di stabilità e di monotonia dell’esistere quotidiano, come sosteneva qualche recensore del regime.
Era invece la traccia del fenomeno opposto, riversata nella ricezione letteraria: la precarietà dell’esistere imposta dall’alto, l’avventura vissuta per obbligo. Due realtà che generavano nel lettore il bisogno di altre avventure: autonome, segretamente ramificate in ciascun percorso mentale. Non era autonomia, però. Era solitudine. E Gramsci – quel Gramsci critico della vita letteraria che vedeva fiorire di là dalla prigionia – parteggiava, a modo suo, per Sancio, più che per don Chisciotte. Sancio il concreto, il sarcastico difensore della voce della materia. Sancio, l’umile occhio critico, che si era accorto di quanto c’era di marionettistico, di spudoratamente artefatto, nelle visioni dell’eroe che affiancava. Sancio, a suo modo, anche lui eroe: ma di un eroismo senza riflettori addosso, senza i tempi, i luoghi e le smorfie di chi è costretto a fare il nomade per illudersi che il mondo sia diverso da com’è.
Il guaio è stato che il Sancio di Gramsci nessuno lo ha mia ascoltato abbastanza, mentre forse è proprio dalla sua amarezza, dal suo umanesimo così tagliente, pur nelle smorfie e nelle sue paure rimaste a mezza voce, che bisognerebbe ricominciare a riflettere, anche oggi. Jost de Bloois (Amsterdam), Frans-Willem Korsten (Leiden) e Monica Jansen (Utrecht) hanno introdotto il convegno parigino indicando tre prospettive: ripensare l’idea di autonomia culturale, con l’idea che nulla si pensa né si fa da soli,, nei precipizi biopolitici del capitalismo globale; rivedere i modi di rappresentazione della precarietà, la funzione di un narrare-per-interpretare, dove la storia non raffigura soltanto lo spazio e il tempo del precariato, ma ne ricerca le radici, le mutazioni e le premesse morali; ne svela, cioè, gli incastri, i giochi illusionistici che ne tengono in vita l’immagine di necessità dell’epoca che viviamo. Infine, nel campo dell’analisi sociologica, guardare alle piccole esperienze, ai singoli luoghi di sviluppo del pensiero critico, e a tutto ciò che hanno da insegnare a tutti noi, alterandone il meno possibile fini e strutture.
Non una critica come utopia, quindi: piuttosto una specie di endoutopia, di fotografia delle piccole situazioni, nelle quali il destino di precarietà dell’essere umano si ridiscute e magari si rovescia, una buona volontà facendo tornare a respirare e a vedere un po’ più lontano.
Nel sud-ovest del Messico, a Oaxaca, esiste una Universidad de la Tierra, che è una comunità di apprendimento, di riflessione e di azione politica: ne hanno parlato a Nanterre Gustavo Esteva, uno dei fondatori, e Irene Ragazzini, italiana, che ci lavora da qualche anno. Un convivio – la parola chiave è questa, convivio come primo accesso al buon vivere – di sapere e di volontà politica, che ha qualcosa dell’esperienza pedagogica di Ivan Illich, e qualcos’altro di quel nesso fra storia e rivoluzione che Walter Benjamin attribuiva alla distruzione delle gerarchie – di tutte le gerarchie, anche quelle di apparato o di partito – e della loro idea di progresso che non si arresta.
Sono i luoghi in cui agisce il fantasma benigno di una storia antistoricistica: buchi nella rete globale, e in tutto il torpore delle idee da essa indotto. Anfratti di dialogo, nei quali riprende vita quella vecchia, cara idea bianciardiana, del lavoro culturale: l’opera di chi sa chiedersi ad ogni passo se, e a chi, tutto ciò che sta facendo può servire. Qualcosa che ci si aspetterebbe, per la verità, dalla vita universitaria, e che il più delle volte si polverizza, invece, nella resa di troppa accademia alla necessità del precariato, e alla creazione di nuovi eroi dello smarrimento – i dottorandi, gli assegnisti, i ricercatori a tempo più o meno determinato – pronti per la scena internazionale della vita precaria. I bersagli, cioè, di tutto un apparato linguistico deterministicamente schiumoso, pieno di specchietti per allodole e di equivoci: meglio aggiorni il curriculum e più ti chiamano; più fai networking più stai a galla; meglio sai scrivere in progettese, più resti sull’onda traballante del rating della ricerca umanistica.
Ma non ci vuole molto a intravedere in questo gergo i segni di uno stato di crisi, speculare a quello del capitalismo finanziario, e in parte ad essa collegabile. Maurizio Lazzarato – intellettuale con base operativa a Parigi – ha scritto su “alfabeta2”, il 19 marzo scorso, che quella crisi “non è cominciata col disastro finanziario”, ma “è piuttosto il risultato del fallimento del programma neoliberista (fare dell’impresa il modello di qualunque relazione sociale) e della resistenza che la figura soggettiva da questi promossa (il capitale umano l’imprenditore di se stessi) ha incontrato”. Da sottoscrivere totalmente. Soprattutto ora, quando la rincorsa allo sbaraglio da parte di quegli eroi scelti – loro assoluto malgrado, come gli si legge negli occhi – a rappresentare la nostra età su una scena così scivolosa fa intravedere l’ombra di una age of precarity, dai primi anni Novanta a oggi, premuta sulle loro spalle come un timbro: il sigillo di un forzato nomadismo intellettuale, di una variante cosmopolita dell’infelicità. Un’ombra verso la quale gli eroi sono spinti persino da un milieu familiare, che sogna in ognuno di loro il cavaliere che prima o poi tornerà a casa. Tutto ciò, parossisticamente, , proprio in Italia, dove viene fatta poltiglia di ogni ipotesi nazionale (sia detto in senso inattuale e gramsciano, ancora) di ascolto della ricerca, e dove ci si può trovare con il sedere a terra – absit iniuria – molto più facilmente che altrove.
Ed è paradossale, ma dolorosamente vero, che questa immagine dell’eroe precario, del funambolo sulla corda del commercio intellettuale, derivi da una condizione generale di non-responsablità e di conseguente non-scelta di fatto, da una parte di chi non è più precario da molti anni, e che magari non lo è mai stato, almeno nell’accezione corrente di ciò che è precario. Come se quella formula, il coraggio dell’incertezza, fosse un modo per nascondere – in un gioco retorico che ha in sé, occorre ammetterlo, qualcosa di perverso – l’assenza di coraggio della certezza,o almeno dell’illusione istituzionale di un maggior grado di certezza. Come nella giurisprudenza antica, precarium è ciò che dipende da una preghiera, ciò che rimane appeso alla volontà altrui; ma anche, e specularmente, precarius è colui che è costretto a chiedere insistentemente, a fare forza sulla realtà. Nulla di più affine, oggi, alla prassi accademica, le cui energie migliori sono diligentemente orientate a far girare l’ingranaggio nell’armonia prestabilita in entrambi i sensi, senza cigolii.
Non sarà più di tanto utopico, o sterile, provare a rintracciare in una nuova antropologia letteraria i segni di uscita, le maglie rotte della rete. Magari proprio attraverso quell’esercizio critico che ognuno avrebbe il diritto di sperimentare, se conserva una passione per lo studio e riesce, per sua fortuna, a condurla più avanti possibile. Dagli Stati Uniti, dove le humanities oscillano sempre più paurosamente sulla scena del precariato, Federico Luisetti – docente di Italiano, Letterature comparate e Comunicazione a Chapel Hill, nell’Università del North Carolina – ha portato al convegno di Nanterre una sua proficua lettura dell’impulso selvaggio, primitivo della rappresentazione della realtà, cogliendovi il segno caratteristico di una letteratura non più post-coloniale, bensì de-coloniale. Nel suo discorso ritorna, guardando a realtà sino ad oggi marginalizzate, l’idea di “micro politica” che risale ai Mille piani di Gilles Deleuze e Félix Guattari: l’organizzazione molecolare di forze vitali di tensione e di ribellione che intersecano la voce, la forma, il ritmo collettivo delle grandi correnti di cambiamento sociale, e mostrano gli strumenti per uscire, in qualche modo, dalle chiusure di una vita culturale acritica e dogmatica.
Non a caso, forse, tra le narrazioni che scandagliano il tremolare di questi anni, quelle più efficaci – come Il tempo materiale di Giorgio Vasta – si popolano di racconti di sogni: pagine in cui la rappresentazione aperta, ruvida, scavata nella corporeità desolata delle strade di Palermo, sembra interrompersi, e il tempo vissuto prende una forma silenziosa, lenta e pulviscolare. Sono quei sogni, adesso – così sembra di Vasta – che non ci rappresentano, non ci imitano né ci descrivono; piuttosto ci interpretano, tutti noi agitati dal linguaggio gommoso della violenza istituzionale. E sta in quei sogni l’unica sostanza allegorica, fragilissima e libera, che non comporta lo smarrimento, né il sacrificio, di alcun eroe.
Stefano Colangelo.